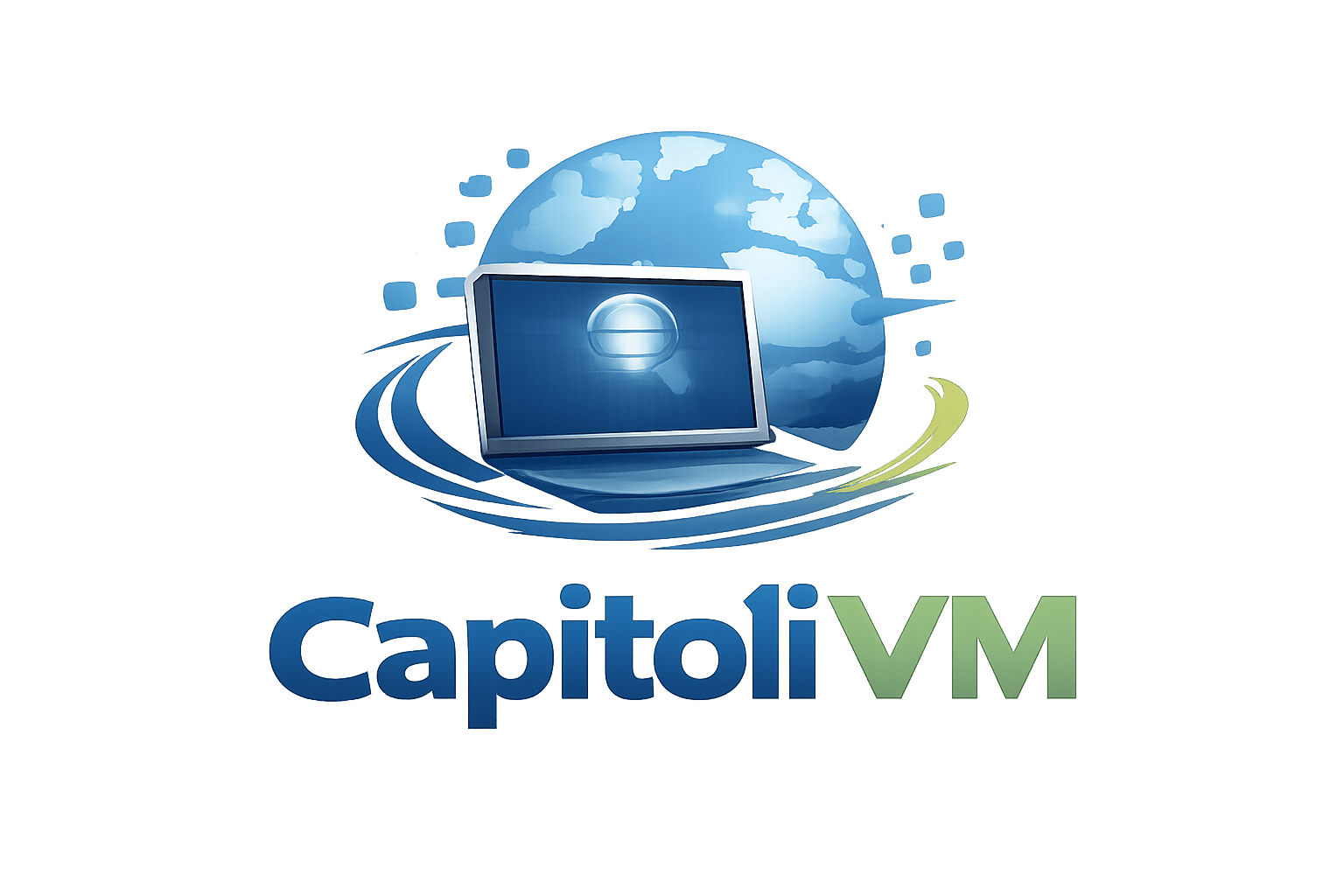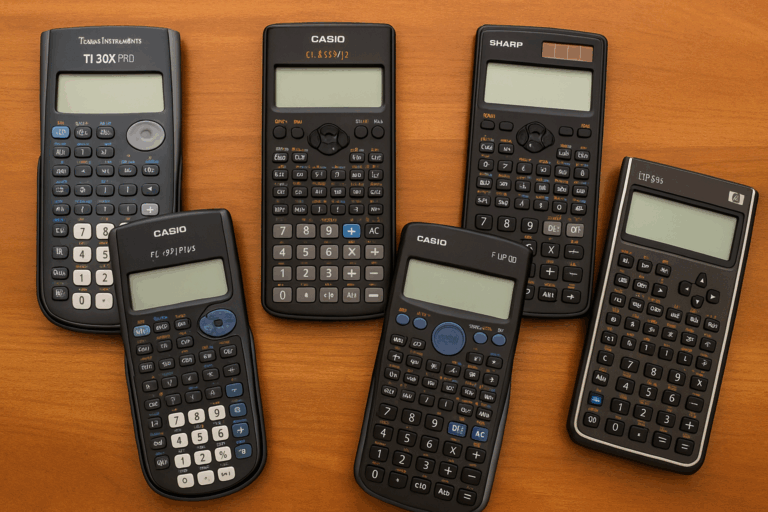La Generazione Z. Un termine che sentiamo e leggiamo ovunque, spesso accompagnato da stereotipi e generalizzazioni. Nati all’incirca tra la metà degli anni ’90 e i primi anni 2010, questi giovani sono cresciuti con internet, gli smartphone e i social media come estensioni naturali del loro essere. Sono la prima generazione di “nativi digitali” veri e propri, e questa loro peculiarità li rende un bacino di studio affascinante e, a volte, complesso da decifrare. Dal mio punto di vista, osservandoli e interagendo con loro, noto un mix di resilienza inaspettata e vulnerabilità nascoste, di pragmatismo e idealismo. Non sono solo “quelli dei TikTok” o “quelli sempre al telefono”, ma una forza motrice con prospettive uniche e, sì, delle sfide concrete che la società ha il dovere di comprendere e affrontare, ma anche delle opportunità che possono ridefinire il nostro futuro.
Il bivio digitale: connessione o isolamento?
La sfida e l’opportunità più evidenti per la Gen Z risiedono senza dubbio nel loro rapporto viscerale con il digitale. Da un lato, la tecnologia offre loro una connessione senza precedenti. Possono apprendere qualsiasi cosa con un clic, connettersi con persone da ogni angolo del mondo, esprimere la propria individualità su piattaforme globali e mobilitarsi rapidamente per cause sociali e ambientali. Sono globali per natura, meno legati ai confini fisici e mentali delle generazioni precedenti. Questa iper-connessione può tradursi in una creatività sfrenata e in un’inedita capacità di problem-solving collaborativo.

Tuttavia, il rovescio della medaglia è altrettanto tangibile. La pressione costante dei social media, il confronto incessante con vite filtrate e idealizzate, l’esposizione al cyberbullismo e la difficoltà di distinguere la realtà dalle bolle online, possono generare un senso di ansia, insicurezza e solitudine. La dipendenza dagli schermi può erodere le competenze relazionali “offline” e la capacità di gestire l’attesa o la noia. Il bivio è chiaro: il digitale può essere un ponte verso infinite possibilità o un muro che amplifica l’isolamento e le fragilità psicologiche.
Oltre il profitto: un nuovo senso di scopo
Un’altra caratteristica distintiva della Generazione Z è il loro approccio al lavoro e al futuro, spesso molto diverso da quello dei loro predecessori. Cresciuti in un’epoca di crisi economiche, cambiamenti climatici e incertezze geopolitiche, molti di loro non sono motivati unicamente dal profitto o da una carriera tradizionale in un’unica azienda per tutta la vita. Cercano un senso di scopo, un impatto positivo. Vogliono lavorare per aziende che riflettano i loro valori, sono attenti alla sostenibilità, alla giustizia sociale e alla diversità. Questo li rende agenti di cambiamento potenti nel mondo aziendale, spingendo le organizzazioni a essere più etiche e responsabili.
L’opportunità qui è enorme: una forza lavoro che non solo produce, ma che si preoccupa del “come” e del “perché” di ciò che fa, può portare a innovazioni radicali e a un capitalismo più consapevole. La sfida, però, è trovare il giusto equilibrio tra le loro aspirazioni idealistiche e le realtà pratiche del mercato del lavoro, spesso ancora rigide e legate a modelli più tradizionali. Devono imparare a navigare le complessità del mondo reale senza perdere la loro spinta ideale, e la società deve essere pronta ad accogliere e valorizzare questa nuova visione, offrendo percorsi professionali che permettano di coniugare passione, scopo e sostenibilità economica.
Quali sono le critiche mosse alla Generazione Z?

Le critiche mosse alla Generazione Z sono varie e spesso si sovrappongono a quelle tradizionalmente rivolte a ogni nuova generazione emergente. Tuttavia, alcune di esse sono amplificate dalla loro profonda immersione nel mondo digitale e dalle particolari sfide sociali e ambientali che hanno ereditato.
Una delle critiche più diffuse riguarda la presunta “fragilità emotiva” o una minore resilienza. Si sostiene che questa generazione sia più incline all’ansia, alla depressione e che abbia una minore tolleranza alla frustrazione rispetto alle generazioni precedenti. Questo viene spesso collegato all’esposizione costante ai social media, dove il confronto sociale è amplificato e la ricerca di approvazione online può portare a insicurezze. L’idea di dover mantenere una “facciata” perfetta sui social, unita alla possibilità di essere esposti a cyberbullismo o critiche, può incidere negativamente sulla loro salute mentale, rendendoli meno preparati ad affrontare le difficoltà del mondo reale.
Un’altra critica è legata alla dipendenza dalla tecnologia e agli schermi. Si osserva una difficoltà a disconnettersi, con conseguenze sulla qualità del sonno, sulle interazioni sociali offline e sulla capacità di concentrazione. La loro abitudine a consumare contenuti “mordi e fuggi” e la sovrastimolazione digitale porterebbero a una ridotta capacità di attenzione e a una preferenza per informazioni superficiali piuttosto che per approfondimenti complessi. Questo, secondo i critici, si rifletterebbe anche nel mondo del lavoro e dell’apprendimento, dove la pazienza e la perseveranza sarebbero meno sviluppate.
Infine, spesso viene loro attribuita una certa mancanza di esperienza e pragmatismo, o una visione troppo idealistica del mondo del lavoro e della società. Cresciuti in un’era di instabilità economica e cambiamenti rapidi, si dice che abbiano aspettative irrealistiche riguardo alla carriera, alla flessibilità e al work-life balance, talvolta sottovalutando la necessità di sacrificio e duro lavoro che le generazioni precedenti hanno dovuto affrontare. Questa critica, tuttavia, è spesso vista come ipocrita, poiché le sfide economiche e ambientali che la Gen Z affronta sono in gran parte eredità delle generazioni precedenti, e il loro idealismo può essere interpretato come un desiderio legittimo di costruire un mondo migliore, piuttosto che un mero disinteresse per le “regole” stabilite.

Da anni sono copywriter e redattore di blog di tematiche tech e internet. Tra le mie passioni il mondo tech e digital. Per il blog capitolivm.it mi occupo della realizzazioni di guide su sicurezza informatica, web e digital.