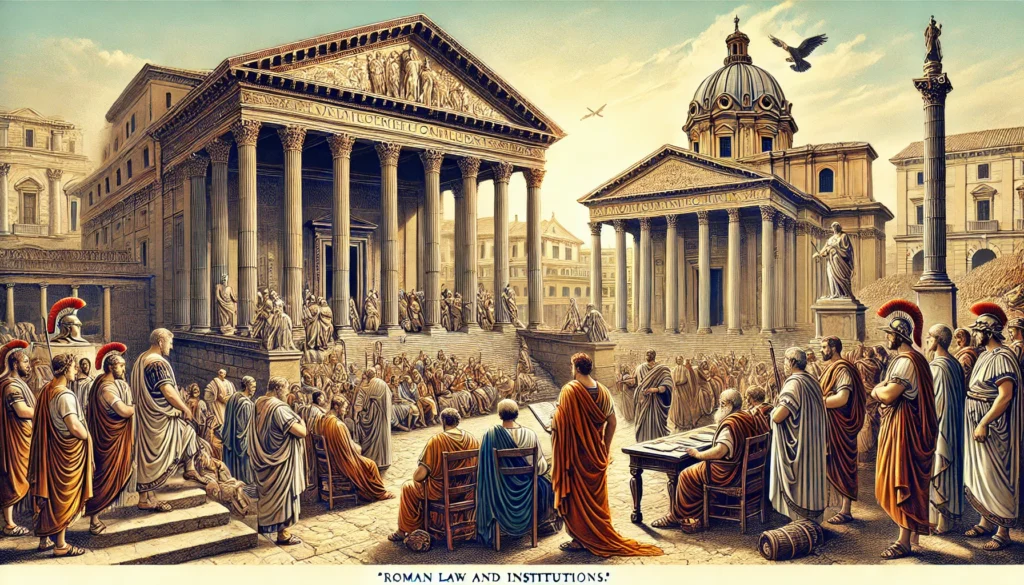
Il diritto romano
Il diritto romano fu l’ordinamento giuridico che accompagnò la storia di Roma dalla sua fondazione fino alla caduta dell’Impero. Nei secoli successivi, e fino all’elaborazione dei moderni codici, il diritto romano venne ripreso e utilizzato da molti popoli che abitavano i territori un tempo sotto il dominio romano. Nei primi secoli di Roma, il diritto (ius) si fondava principalmente sulla tradizione. Non esistevano leggi scritte; la regolamentazione della vita quotidiana si basava su una prassi accettata collettivamente, secondo le usanze degli antenati (mos maiorum). Il primo documento di legge scritta fu rappresentato dalle Dodici Tavole, redatte nel V secolo a.C.
Con il tempo, le leggi venivano proposte dai magistrati e votate dai comitia. Il più antico diritto civile, lo ius civile, era noto anche come ius quiritium, ossia il diritto dei cittadini romani. Lo ius honorarium (o praetorium) includeva le norme introdotte dai magistrati, in particolare dai pretori, per interpretare, correggere o ampliare lo ius civile. Questo diritto comprendeva anche le leggi promulgate dai comizi (leges), dai concili plebei (plebiscita), dal senato (senatus consulta) e, in età imperiale, dalle costituzioni imperiali (constitutiones).
Il diritto romano si divideva principalmente in ius publicum e ius privatum: il primo riguardava la costituzione dello stato e le norme di interesse pubblico, mentre il secondo trattava i diritti dei singoli individui. Lo ius gentium regolava le relazioni tra stati indipendenti, equivalente al moderno diritto internazionale, e comprendeva anche le norme giuridiche arricchite dai contatti con altri popoli. Lo ius italicum si applicava al territorio italiano, che era esente dalla tassazione fondiaria (tributum soli); questo privilegio, durante l’impero, poteva essere concesso anche ad alcune municipalità provinciali.
In generale, la legge veniva utilizzata solo in casi eccezionali ed era considerata uno strumento per intervenire sulle tradizioni, modificandole quando queste venivano ritenute inique, dannose o inadatte alle nuove esigenze della società. La legge non aveva sempre un carattere normativo rigido, ma si presentava come un’alternativa alla tradizione, lasciando ai cittadini la libertà di scegliere se seguire i canoni tradizionali o i nuovi istituti a seconda delle circostanze.
La sistemazione in età imperiale
A partire dal II secolo a.C. e fino al 126 d.C., quando l’imperatore Adriano incaricò il giurista Salvio Giuliano di riorganizzarlo in maniera definitiva, fu in vigore il cosiddetto editto perpetuo del pretore. Questo editto veniva aggiornato ogni anno con nuove formule, che erano basate su quelle già esistenti, ma modificate per adattarsi a nuovi casi e situazioni. Le formule precedenti venivano corrette, integrate con eccezioni, garanzie e innovazioni. Attraverso questo processo di revisione continua, il diritto romano si sviluppò e si perfezionò, raggiungendo un alto grado di completezza. Nonostante ciò, il diritto civile e il diritto pretorio rimasero due sistemi distinti fino al periodo postclassico, quando si iniziò a integrarli in un unico corpus giuridico.
Una tappa cruciale per il diritto romano fu la Costituzione di Caracalla del 212 d.C., che estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero, estendendo così l’applicazione del diritto romano a tutti i popoli sotto il dominio di Roma. Con la diffusione del cristianesimo, il diritto romano subì diverse modifiche, specialmente in ambiti come la famiglia, la schiavitù e i rapporti tra creditori e debitori, con un’attenzione maggiore alle esigenze di questi ultimi in determinate circostanze.
Per garantire maggiore chiarezza e certezza del diritto, l’imperatore d’Oriente Giustiniano intraprese una vasta opera di raccolta e riorganizzazione del materiale legislativo e dei testi giuridici classici, culminata nel Corpus iuris civilis (528-533). Sebbene ispirata ai principi del diritto romano classico, questa operazione, motivata da esigenze pratiche di rapida consultazione e miglior funzionalità delle istituzioni giuridiche imperiali, introdusse diverse correzioni e adattamenti per allinearsi alle nuove procedure e concezioni giuridiche dell’epoca.
In Occidente, il diritto romano subì un declino durante l’Alto Medioevo, caratterizzato da un processo di semplificazione e volgarizzazione. Tuttavia, successivamente, esso tornò a essere studiato e applicato in maniera più sistematica, specialmente nell’area del Sacro Romano Impero.
