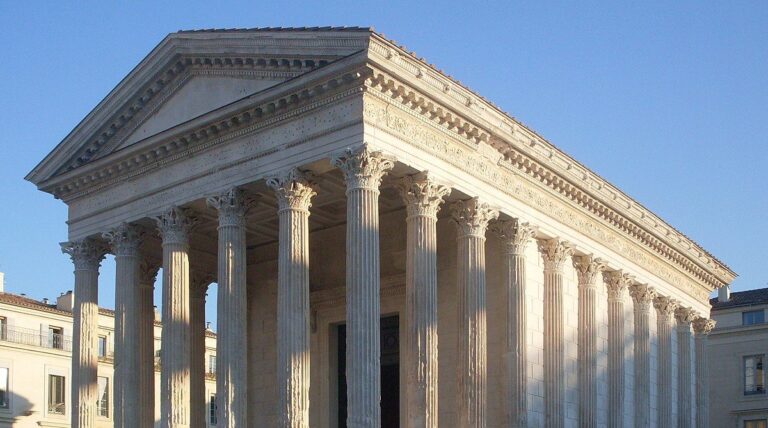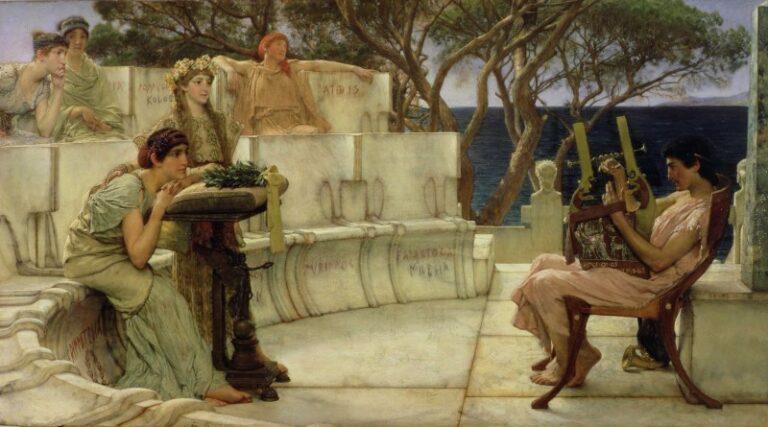Le unità di misura usate dagli antichi romani durante le loro attività agricole, commerciali e nella vita quotidiana:

Le misure di peso nell’Antica Roma
Alcune di queste unità di misura avevano gli stessi nomi di alcune monete. Ciò si spiega col fatto che, in origine, le monete non erano che pezzi di metallo di un determinato peso: così, ad esempio, la moneta detta “asse” era di bronzo e pesava un asse (ovvero 323 grammi).
| ASSE o LIBBRA | Unità (kg 0.323) |
| QUADRANTE | 1/4 di asse (g 81.86) |
| SESTANTE | 1/6 di asse (g 54.57) |
| ONCIA | 1/12 di asse (g 27.28) |
| SEMI-ONCIA | mezza oncia (g 13.64) |
| SCRUPOLO | 1/24 di oncia (g 1.14) |
La groma era uno strumento essenziale utilizzato dai Romani per tracciare allineamenti perpendicolari sul terreno, necessari per la progettazione di nuove città, quartieri e strade, oltre che per suddividere il territorio in quadrati o rettangoli utili al calcolo delle superfici. La sua struttura comprendeva un’asta verticale infissa nel terreno, dalla cui sommità si estendevano due aste ortogonali tra loro, sorrette da un braccio.
Alle estremità di queste aste erano presenti fori equidistanti, dai quali pendevano fili a piombo, disposti in modo da essere perpendicolari a coppie. La groma era realizzata prevalentemente in legno, con alcune parti rivestite in metallo, soprattutto nelle zone più soggette a usura o di maggiore importanza.