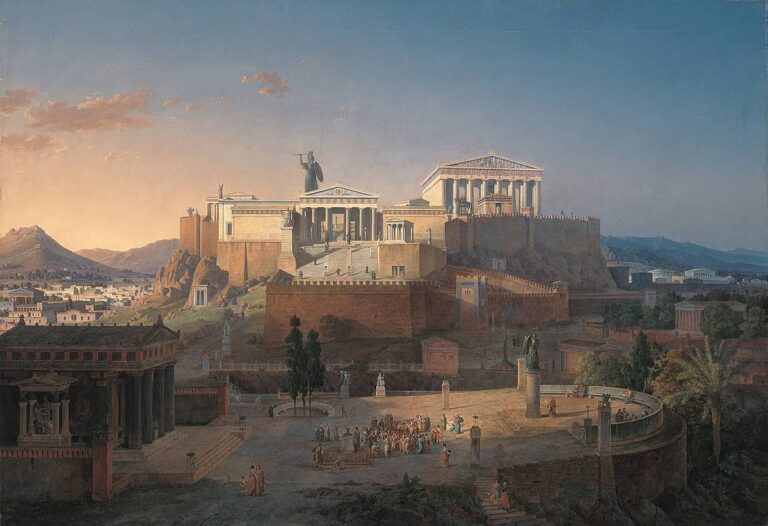La battaglia di Zama segnò l’epilogo della seconda guerra punica, infliggendo a Cartagine una sconfitta definitiva che ne compromise la forza militare e politica, consentendo a Roma di affermarsi come potenza dominante nel Mediterraneo. Lo scontro si svolse tra il 18 e il 19 ottobre del 202 a.C., nelle vicinanze della città di Zama, appartenente all’impero punico, e vide contrapposti due dei più celebri strateghi dell’antichità: Annibale Barca, alla guida dei Cartaginesi, e Publio Cornelio Scipione, noto poi come “L’Africano”, al comando delle forze romane.

Annibale iniziò la battaglia con l’impiego degli elefanti da guerra, ma i romani, ormai esperti nel fronteggiare questi animali, li disorientarono con il suono delle trombe e forti grida. Impauriti, molti elefanti si riversarono sulla cavalleria numidica posizionata sull’ala sinistra dell’esercito cartaginese, seminando il caos tra le loro file. Scipione colse l’opportunità e ordinò a Massinissa, posto a fronteggiare questa cavalleria, di attaccare con i suoi uomini, sbaragliando definitivamente il nemico.
Nonostante alcuni elefanti non si fossero spaventati, lanciandosi contro la fanteria romana, i veliti risposero tempestivamente bersagliandoli da lontano. Gli animali, colpiti dalle frecce, cercarono di trovare vie di fuga, ma i manipoli degli hastati, sfruttando lo spazio, si spostarono per creare dei passaggi all’interno dello schieramento romano. Gli elefanti passarono attraverso questi “corridoi”, sotto il tiro continuo dei veliti e dei principes, finendo per dirigersi verso l’altra ala della cavalleria cartaginese.
Le condizioni di pace imposte da Roma a Cartagine prevedevano la cessione della Spagna, il riconoscimento ufficiale del regno di Numidia sotto il controllo di Massinissa, che agiva come alleato romano, e la consegna della flotta cartaginese, con il divieto di intraprendere azioni militari senza l’approvazione di Roma.