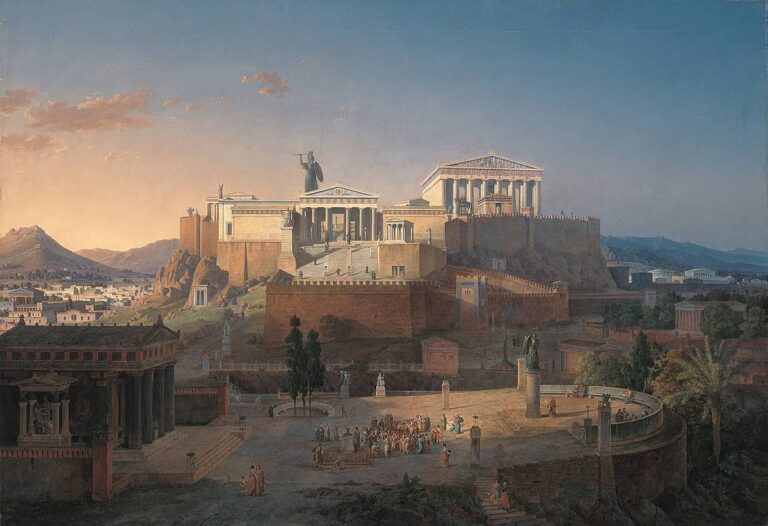Le origini degli Unni sono avvolte nel mistero. Sappiamo con certezza soltanto che si trattava di un popolo nomade proveniente dall’immensa steppa eurasiatica. Poiché non utilizzavano la scrittura, non ci sono pervenuti documenti diretti da parte loro, e la loro appartenenza linguistica rimane incerta a causa della scarsità di nomi unni che ci sono stati tramandati. Le fonti romane iniziano a menzionarli improvvisamente solo verso la fine del IV secolo d.C.
Esiste una teoria, non priva di difficoltà interpretative, secondo cui gli Unni potrebbero essere la stessa popolazione nomadica nota come Hsiung-nu, che circa tre secoli prima aveva minacciato le frontiere settentrionali della Cina degli Han. Tuttavia, non abbiamo informazioni certe sulle cause che, dopo la metà del IV secolo, spinsero gli Unni a migrare verso occidente. Ciò che è certo è che la loro pressione costrinse i Goti a spingersi fino al Danubio nell’estate del 476. Gli Unni erano cavalieri eccezionali e abili arcieri. Pur non utilizzando le staffe, impiegavano selle di legno pesante che garantivano una presa solida e una piattaforma stabile per il tiro.

La minaccia rappresentata dagli Unni segnò una svolta cruciale nei rapporti tra Goti e Romani, spingendoli verso un accordo. Tuttavia, il fallimento di questa intesa, in un momento in cui la presenza unna non era ancora consolidata lungo le frontiere imperiali, portò alla catastrofe di Adrianopoli e innescò una crisi militare all’interno dell’Impero romano. È certo che intorno alla metà del V secolo, un grande numero di Unni si era insediato stabilmente nell’Europa orientale, occupando la vasta pianura ungherese a ovest dei Carpazi. Questo stanziamento fu preceduto, attorno al 405, da un evento simile a quello verificatosi nel 376, ma su una scala molto più ampia: mentre la crisi del 376 era stata causata dall’occupazione di territori a nord del Mar Nero, nel 405 fu l’arrivo degli Unni nella pianura ungherese a spingere popolazioni come Vandali, Alani, Svevi, Burgundi e i seguaci di Radagaiso oltre i confini romani. Pertanto, è plausibile che l’ingresso massiccio dei barbari all’interno dell’Impero nei primi anni del V secolo non fosse tanto il risultato della debolezza romana, quanto dell’impatto destabilizzante dell’arrivo degli Unni in Europa centrale.
Nonostante le difficoltà, Roma poteva ancora contare su figure energiche capaci di risollevarne le sorti. Tra queste, una delle più importanti fu il generale Ezio, l’ultima grande figura in grado di affrontare la situazione in Occidente. Ezio, inizialmente al servizio dell’Impero d’Oriente, aveva trascorso un periodo come ostaggio di Alarico e poi come prigioniero degli Unni. Nel 433, rinunciando alla porpora, prese le redini del potere alla corte di Ravenna e nei successivi anni riuscì a respingere Franchi e Alamanni oltre il Reno, nonché a sottomettere Burgundi e Alamanni. Tuttavia, i suoi sforzi di stabilizzazione dell’Occidente furono compromessi dall’invasione delle province africane da parte dei Vandali di Genserico nel 439, dopo un breve accordo di pace nel 435. I Vandali, giunti fino a Cartagine, privarono Ezio delle risorse indispensabili per il suo piano di riconquista. Un tentativo di contrattacco, organizzato dalla Sicilia nel 440 insieme a Costantinopoli, non andò a buon fine, poiché sorse un pericolo ancora più grave. Fu infatti stipulato un trattato con Genserico nel 442, riconoscendo la sua posizione di re vassallo dell’Impero, di fatto cedendo le ricche province africane ai Vandali.
Il nuovo pericolo, questa volta proveniente da Nord, era rappresentato dal re unno Attila, che pose fine alla collaborazione tra il suo popolo e Roma. Attila apparve sulla scena insieme al fratello Bleda poco prima del 440 e, inizialmente, rinegoziò i rapporti con l’Impero richiedendo a Costantinopoli il raddoppio del tributo annuale, portato da 350 a 700 libbre d’oro. Sebbene questa richiesta venisse accettata, le tensioni presto sfociarono in conflitti a causa della mancata restituzione di prigionieri. Gli Unni attraversarono il Danubio e conquistarono varie fortificazioni e città di confine, inclusa la fondamentale base militare di Viminacium e la strategica Naisso, chiave di accesso ai Balcani. In questa campagna, gli Unni dimostrarono un’abilità sorprendente nel condurre assedi, impressionando i Romani con la loro crescente capacità di operare su terreni fortificati, oltre che in battaglie aperte.

Gli Unni, ben informati dei preparativi militari di Bisanzio per una spedizione in Africa e del conseguente dispiegamento di un imponente contingente, si trovavano ormai nella posizione di poter minacciare la stessa Costantinopoli. Attila costrinse l’Impero d’Oriente a firmare una pace umiliante tra il 442 e il 443, imponendo un forte aumento del tributo. Successivamente, nel 444 o 445, Attila si sbarazzò del fratello Bleda, consolidando il proprio potere assoluto e facendo nascere a Costantinopoli speranze di ribellione, tanto che si tentò di ritardare i pagamenti in oro dovuti agli Unni. Attila reagì con forza, lanciando una nuova invasione nel 447, approfittando anche del terremoto che aveva compromesso le mura della capitale. Sebbene le circostanze fossero favorevoli, Attila non riuscì a portare Costantinopoli sotto assedio, ma devastò i Balcani e le coste dell’Egeo. Intanto, aveva costruito un impero personale, aggregando sotto il suo comando numerose tribù barbariche incontrate durante le sue campagne di conquista.
Le fonti riportano che Attila avrebbe contemplato una campagna contro la Persia, anche se non vi sono certezze in merito. Ciò che è noto è che il sovrano unno decise infine di rivolgersi contro l’Occidente, forse incoraggiato da Onoria, sorella dell’imperatore Valentiniano III e figlia di Galla Placidia. Nel 451, Attila, alla guida di un vasto esercito, attraversò il Reno nei pressi di Coblenza e avanzò in Gallia. Ezio, a capo delle truppe romane e di un’eterogenea coalizione di alleati, tra cui Burgundi e Visigoti, rispose con prontezza. Attila, giunto nei pressi di Orléans, si ritirò verso est, e nei pressi dei Campi Catalaunici, in un luogo non identificato con certezza, si svolse un’epica battaglia che costrinse gli Unni a ritirarsi. Ezio era riuscito a fermare l’avanzata di Attila.
Attila passò l’inverno pianificando un’altra campagna. Nella primavera del 452 superò le Alpi e assediò Aquileia, che oppose una resistenza tenace ma, infine, cedette. Da lì, Attila conquistò rapidamente diverse città della pianura padana, inclusa Milano. Tuttavia, questo successo non si rivelò duraturo. Poco tempo dopo, a seguito di un incontro con un’ambasceria guidata da papa Leone, Attila decise di ritirarsi. La tradizione attribuisce grande merito alla capacità persuasiva del pontefice, ma è probabile che altri fattori abbiano influenzato la ritirata: l’esercito di Attila era ormai senza le risorse logistiche necessarie per una lunga campagna e subiva pressioni dal nuovo sovrano di Costantinopoli, Marciano, che aveva inviato rinforzi ad Ezio e attaccava le retrovie unne a nord del Danubio. Trovandosi in una posizione difficile, Attila preferì negoziare una tregua e ritirarsi rapidamente verso il cuore dell’Europa.

Credit line: (c) (c) Royal Academy of Arts / Photographer credit: John Hammond /
Le campagne in Occidente evidenziarono la fragilità strutturale dell’impero unno, che mancava di una solida capacità di pianificare operazioni militari a lungo termine. L’esercito di Attila si sosteneva quasi esclusivamente attraverso il saccheggio, un metodo incerto e instabile per garantire rifornimenti continui. Nonostante questa debolezza logistica, Attila, sempre desideroso di guerre e conquiste, stava già organizzando una nuova campagna militare su vasta scala quando la morte lo colse nella notte del suo matrimonio. Con la sua scomparsa si dissolse anche la minaccia unna, che aveva scosso profondamente l’Impero romano senza riuscire, tuttavia, a destabilizzarlo completamente.
Pur avendo sviluppato una certa abilità negli assedi, Attila non disponeva di una flotta, una carenza che gli precludeva l’accesso alle province orientali dell’Impero, come l’Asia Minore, la Siria e l’Egitto. Anche in Occidente, la sua capacità di stabilire un dominio duraturo era limitata. Più che conquiste dirette, furono le conseguenze indirette delle sue azioni a esacerbare la crisi dell’Impero d’Occidente. In Spagna, Ezio non poté intervenire efficacemente, nonostante i Vandali avessero lasciato la penisola nel 429, e così gli Svevi ampliarono il loro controllo dalla Galizia fino alla Lusitania e alla Betica. Un tentativo di riconquista tra il 442 e il 446 fallì, e al momento del ritiro di Attila nel 452, l’Impero d’Occidente aveva ormai perso il controllo su molte province: Britannia, gran parte della Spagna, le ricche province dell’Africa settentrionale e la Gallia meridionale, riducendo drasticamente le sue entrate e compromettendo la sua capacità militare.
L’impero unno, costruito rapidamente, crollò con altrettanta velocità. I popoli sottomessi durante le conquiste di Attila riacquisirono presto la loro indipendenza, poiché i successori del re unno non riuscirono a mantenere il controllo su di loro. La struttura dell’impero unno era infatti politicamente instabile e soggetta a numerose tensioni interne. La forza degli Unni risiedeva paradossalmente nella stessa caratteristica che ne decretò la fragilità: il potere era sostenuto dalla continua sottomissione di nuovi popoli, ma gli Unni non disponevano delle strutture amministrative necessarie per governare direttamente i territori conquistati, a differenza dei Romani, che avevano sviluppato un’efficace burocrazia. Ogni vittoria contribuiva a rafforzare il dominio unno, ma non poteva eliminare le tensioni interne. Attila, per mantenere il potere, aveva bisogno di successi militari costanti; quando questi iniziarono a mancare, anche il suo controllo sui popoli più periferici iniziò a sgretolarsi. La morte di Attila scatenò una guerra civile tra i suoi figli, accelerando ulteriormente il crollo dell’impero unno.