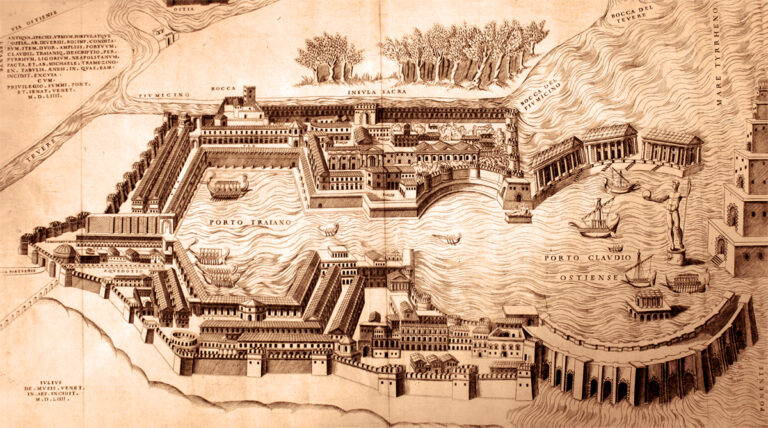Marco Emilio Lepido: il Terzo Uomo del Secondo Triumvirato
Quando si parla del celebre secondo triumvirato, formato nel 43 a.C., il nome di Marco Emilio Lepido viene sempre citato per ultimo, quasi come una nota a margine. A differenza di Ottaviano e Marco Antonio, che non nascondevano il loro desiderio di primeggiare e replicare le gesta di Giulio Cesare, Lepido sembra essere spesso relegato in secondo piano. Tuttavia, anche lui, uomo politico abile e generale esperto, ebbe un ruolo significativo in quegli anni turbolenti e tentò di ritagliarsi il suo spazio nella grande storia di Roma.
Le Origini e l’Ascesa Politica di Lepido
Marco Emilio Lepido nacque intorno al 90 a.C. a Roma, in seno alla nobile Gens Aemilia, una delle famiglie più illustri e influenti della Repubblica. Gli Aemilii vantavano una lunga tradizione di cariche prestigiose, e i segni del loro potere erano visibili ovunque: dalla basilica nel Foro Romano al celebre ponte Aemilius, oggi noto come Ponte Rotto. Tra i suoi antenati più illustri si annovera Lucio Emilio Paolo, console e figura eminente nella storia di Roma.
Grazie a questo solido retaggio, Lepido ebbe una giovinezza agiata e un’educazione impeccabile, che gli consentirono di intraprendere rapidamente il cursus honorum. Già nel 52 a.C., il Senato lo nominò interrex, un incarico cruciale che prevedeva la convocazione dei comizi centuriati per eleggere nuovi consoli. Ma il vero punto di svolta nella sua carriera fu l’alleanza con Giulio Cesare, il grande condottiero che dominava la scena politica dell’epoca.
Lepido divenne uno degli uomini di fiducia di Cesare, tanto che Plutarco lo definisce “il più grande amico” del dittatore. Questo rapporto privilegiato lo portò a ricoprire cariche di rilievo: fu pretore nel 49 a.C., governatore della Spagna Citeriore e, successivamente, console. Tra il 46 e il 44 a.C., fu nominato magister equitum, il secondo uomo più potente dopo Cesare stesso. Questo ruolo gli conferiva un potere quasi assoluto, subordinato unicamente al volere del dittatore.
Quando Cesare fu assassinato nel 44 a.C., Lepido si trovò improvvisamente in una posizione delicata. Secondo alcune fonti, come Cassio Dione, anche lui era nel mirino dei congiurati, ma riuscì a salvarsi. La sera prima dell’attentato, Cesare aveva trascorso del tempo proprio con Lepido, segno della fiducia che riponeva in lui.
Il Gioco Politico: Lepido e Marco Antonio
Dopo la morte di Cesare, Lepido dovette affrontare la difficile eredità politica del suo mentore. In un clima di instabilità e divisione, la sua posizione era tutt’altro che sicura. Tuttavia, grazie al controllo di parte dell’esercito cesariano, riuscì a ritagliarsi un ruolo chiave.
Nel caos che seguì l’assassinio di Cesare, emerse una figura dominante: Marco Antonio. La Repubblica era spaccata, con il Senato e le istituzioni repubblicane sempre più deboli, mentre potenti uomini politici manovravano le legioni come strumenti personali. Marco Antonio cercava di consolidare il suo potere, ma la situazione era tutt’altro che stabile. Secondo Velleio Patercolo, “Roma languiva, oppressa dalla dominazione di Antonio.”
Lepido, con il suo innato opportunismo, decise di allearsi con Marco Antonio. Questa mossa gli valse l’appoggio del potente generale, che lo ricompensò con la carica di pontifex maximus, il titolo religioso più importante di Roma. Velleio Patercolo, tuttavia, definisce questa nomina un’operazione poco limpida, descrivendola come un “imbroglio” volto a sottrarre la carica che era stata di Giulio Cesare.
Nel frattempo, Lepido si spostò in Gallia, apparentemente per proseguire le conquiste militari e le riforme civili iniziate da Cesare. Ma, come osserva Cassio Dione, le sue ambizioni erano ben più alte: “Con il pretesto di vendicare Cesare, Lepido sperava di accrescere il proprio potere, pronto a scatenare una guerra se necessario.” Questo lo rese una figura temuta, persino da Marco Antonio, che riconosceva l’influenza di Lepido sulle legioni.
L’Incontro con Ottaviano e il Secondo Triumvirato
In questo contesto di rivalità e giochi di potere, comparve un nuovo attore: Ottaviano, il giovane erede di Giulio Cesare. Lepido, che nel frattempo aveva consolidato la sua posizione politica e militare, si trovò a dover gestire un equilibrio sempre più precario tra Antonio e il rampante Ottaviano. Questo confronto avrebbe portato alla formazione del secondo triumvirato nel 43 a.C., un’alleanza che avrebbe segnato un nuovo capitolo nella storia della Repubblica Romana.
Nonostante il suo ruolo di mediatore e alleato, Lepido si trovò gradualmente marginalizzato da Antonio e Ottaviano, che miravano entrambi al controllo assoluto. Sebbene abbia contribuito in modo significativo agli eventi del suo tempo, la sua figura è spesso oscurata dai protagonisti più carismatici.
Un Uomo tra Opportunismo e Ambizione
Marco Emilio Lepido resta una figura complessa, un politico e generale abile che sfruttò ogni occasione per mantenere il suo posto nel complicato scacchiere del I secolo a.C. La sua vicenda, però, è anche quella di un uomo incapace di emergere tra giganti come Antonio e Ottaviano, rimanendo sempre sullo sfondo di una storia più grande.

Il Rapporto con Ottaviano e il Secondo Triumvirato
L’ascesa di Ottaviano rese ancora più complesso il già caotico panorama politico romano, mettendo in luce uno degli aspetti più distintivi di Marco Emilio Lepido: la sua ambiguità. Figura di spicco nell’Urbe del I secolo a.C., Lepido aveva già guadagnato grande visibilità grazie a successi militari e riconoscimenti importanti, come il trionfo per le campagne in Spagna (48-47 a.C.) e la salutatio imperatoria del 44 a.C., concessa per aver negoziato una temporanea tregua con Sesto Pompeo. In quest’occasione gli venne persino eretta una statua nei Rostra del Foro Romano, simbolo della sua influenza politica.
Dopo l’assassinio di Cesare, Lepido inizialmente si presentò come un difensore della Repubblica. Tuttavia, ben presto si alleò con Marco Antonio, condividendo con lui sia le difficoltà che le opportunità offerte dalla crisi politica. Questa scelta gli costò la nomina a hostis publicus insieme ad Antonio, quando Ottaviano, sostenuto da uomini come Cicerone, iniziò a mettere pressione sui cesaricidi e su tutti i loro sostenitori. Nonostante la dichiarazione di nemico pubblico, l’esercito di Lepido rimase fedele a lui, dimostrando quanto fosse solido il suo comando sulle legioni.
La crescente instabilità spinse i tre principali contendenti – Ottaviano, Antonio e Lepido – a trovare un accordo. Così, il 26 novembre del 43 a.C., con l’approvazione del Senato, nacque il Secondo Triumvirato, una tregua politica e militare che puntava a ristabilire un minimo di ordine in una Roma devastata da guerre civili. Sebbene Lepido sia spesso relegato a un ruolo marginale rispetto a Ottaviano e Antonio, non va dimenticato che egli possedeva un’enorme influenza politica e militare. Fu, però, anche un abile opportunista, pronto a mutare alleanze per massimizzare i propri vantaggi personali.
Non stupisce, quindi, che Lepido abbia partecipato attivamente alle liste di proscrizione, lo strumento crudele e spietato adottato dai triumviri per eliminare i loro nemici, accumulare ricchezze e consolidare il potere. Tra i nomi inclusi, non esitò a far aggiungere persino quello di suo fratello Paolo, dimostrando quanto fosse disposto a sacrificare i legami personali per i propri obiettivi politici. Le liste portarono un clima di terrore a Roma, come già era avvenuto ai tempi di Silla.
Con la sconfitta di Bruto e Cassio, principali oppositori del triumvirato, l’alleanza tra Ottaviano, Antonio e Lepido si mantenne, ma iniziò a mostrare crepe sempre più evidenti.
La Fine del Secondo Triumvirato e il Tramonto di Lepido
Dopo la battaglia di Filippi e la successiva guerra di Perugia (41-40 a.C.), che coinvolse il fratello di Antonio, il triumvirato si concentrò su una nuova minaccia: Sesto Pompeo. Figlio di Pompeo Magno, Sesto controllava il Mediterraneo con una potente flotta, arrivando a bloccare i rifornimenti verso Roma e a minacciare la sopravvivenza della città.
Mentre Antonio si trovava impegnato in Oriente, Lepido ricevette il controllo delle province africane. Tuttavia, con il Mediterraneo sotto la pressione di Sesto Pompeo, Lepido colse l’occasione per tentare un colpo di mano. Nel 36 a.C., richiamato in Sicilia con dodici legioni per supportare Ottaviano, decise di sfruttare la situazione per accrescere il proprio potere. Secondo Velleio Patercolo, “Lepido, il più vanitoso degli uomini, aveva unito al suo esercito le forze di Pompeo con l’intento di sfidare Ottaviano.”
Il piano, però, fallì miseramente. Lepido perse il sostegno delle sue legioni, che preferirono schierarsi con Ottaviano, riconoscendo in lui una guida più forte e carismatica. Privato del suo esercito, Lepido fu costretto a capitolare. Ottaviano, magnanimo, gli risparmiò la vita ma lo costrinse all’esilio a Circeo. Come scrive Svetonio: “Augusto lo privò del suo esercito e, su sue suppliche, gli concesse la vita, ma lo confinò in esilio per sempre.”
Nonostante il fallimento, Lepido mantenne il titolo di pontifex maximus fino alla sua morte nel 13 a.C., un residuo simbolico del prestigio che aveva un tempo posseduto.
Lepido: Opportunista o Stratega Dimenticato?
La parabola politica di Marco Emilio Lepido solleva interrogativi su chi fosse davvero questo triumviro spesso trascurato dalla storia. Fu un semplice opportunista che cambiava alleanze in base alla convenienza, o un politico scaltramente consapevole delle dinamiche del potere nella Roma tardo-repubblicana?
Lepido incarnò un modello tipico della sua epoca: un uomo capace di sfruttare le legioni per avanzare la propria carriera, ma incapace di consolidare il proprio potere in modo duraturo. Sebbene abbia cercato di emergere tra figure titaniche come Ottaviano e Antonio, il suo destino fu quello di rimanere all’ombra dei due protagonisti principali.
Il suo contributo alla storia di Roma, però, non va sottovalutato. Lepido dimostrò che, anche nelle sabbie mobili della politica romana del I secolo a.C., era possibile raggiungere le vette del potere con astuzia e pragmatismo. Tuttavia, senza il sostegno delle legioni e una visione chiara, il suo ruolo fu destinato a essere oscurato dai suoi più celebri alleati e avversari.