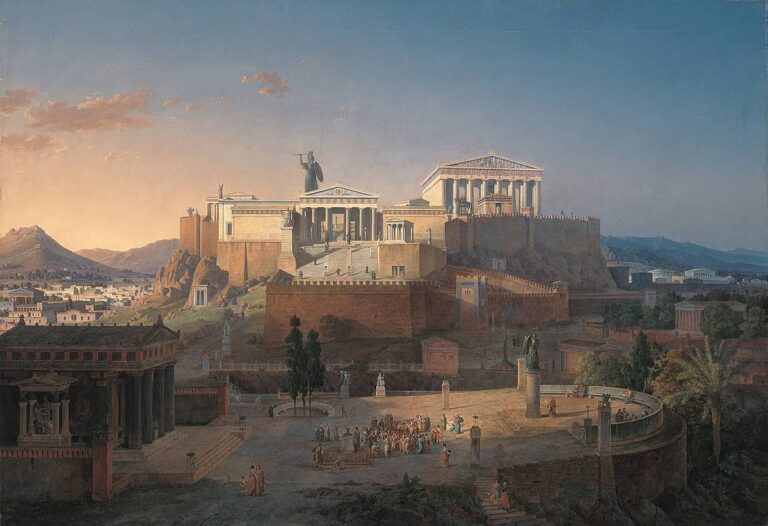Con la vittoria sui Sanniti nel 290 a.C., Roma controllava ormai il Lazio, gran parte della Toscana, quasi tutta l’Umbria, le Marche e la Campania.
L’espansione romana nel sud Italia, tuttavia, era malvista da Taranto, la più prospera e potente città della Magna Grecia. Roma, ormai padrona di gran parte della Penisola, mirava a estendere il proprio dominio per sfidare le città greche nel controllo del Mediterraneo. Nel 282 a.C., la città greca di Turi, vicino a Sibari, chiese aiuto a Roma contro i Lucani, che minacciavano di conquistarla. I Romani videro l’occasione perfetta per avvicinarsi a Taranto con il loro esercito. Dopo aver liberato Turi, lasciarono sul posto alcune legioni. Questo gesto irritò i Tarantini, che, per mostrare il loro disappunto, attaccarono e affondarono alcune navi romane entrate nel Golfo di Taranto. Il Senato romano interpretò questa azione come una grave provocazione e dichiarò guerra. Sentendosi incapaci di affrontare da soli l’esercito romano, i Tarantini chiesero aiuto al re Pirro.

Pirro era considerato uno dei migliori comandanti del suo tempo. Nato nel 318 a.C. nella famiglia reale degli Eacidi, la sua infanzia e adolescenza furono turbolente: costretto all’esilio con il padre quando aveva solo due anni, rientrò per poi essere nuovamente allontanato a causa di una rivoluzione. Salì infine al trono dell’Epiro (attuale Albania) nel 288 a.C. con un piano ben definito: creare un impero greco-occidentale, ampliando il suo regno attraverso la conquista dell’Italia meridionale, della Sicilia e dell’Africa settentrionale. L’invito dei Tarantini gli offriva quindi un’occasione favorevole, forse persino inaspettata, per avviare la sua ambiziosa campagna.
Nel 280 a.C., Pirro sbarcò in Italia con un esercito di ventimila fanti, tremila cavalieri, duemila arcieri e una ventina di elefanti, animali mai visti prima in Italia. I Romani, colpiti da questi possenti animali, li soprannominarono “buoi lucani” dopo averli visti in Lucania.
La grande battaglia tra le forze romane e l’esercito di Pirro si svolse a Eraclea, a circa 70 chilometri da Taranto. Il console Valerio Levino aveva ricevuto l’ordine di respingere il nemico a qualunque costo; Pirro, consapevole dell’importanza della vittoria per i suoi piani di conquista, lanciò subito all’attacco la sua cavalleria, cercando di aggirare le legioni romane sui fianchi. I fanti e cavalieri romani resistettero, ma alla vista degli elefanti fuggirono terrorizzati. Pirro riportò la vittoria, avanzò verso Roma ma, pur accampandosi nei pressi della città, non tentò di attaccarla. Decise invece di ritirarsi verso l’Italia meridionale per prepararsi a un nuovo scontro con le forze romane.
Nella primavera del 279 a.C., la battaglia decisiva ebbe luogo ad Ascoli Satriano, in Puglia. I Romani, ormai abituati alla vista degli elefanti, tentarono di resistere alla loro carica e di difendersi dalle frecce scagliate dai soldati di Pirro posti sopra i pachidermi. La battaglia, intensa e sanguinosa, durò l’intera giornata, ma i Romani furono infine costretti a ritirarsi. Ancora una volta, gli elefanti si rivelarono determinanti. Tuttavia, la vittoria ebbe un costo elevatissimo per Pirro, che, secondo la leggenda, esclamò: “Un’altra vittoria come questa, e tornerò in Epiro senza soldati!”

Pirro era giunto in Italia convinto di vincere rapidamente, ma, trascorso un anno senza aver ottenuto successi decisivi, decise di proporre condizioni di pace. La leggenda racconta che, durante la discussione in Senato sulle sue proposte, il novantenne e cieco senatore Appio Claudio esclamò: «Preferirei essere anche sordo, piuttosto che ascoltare i Romani prendere in considerazione le proposte del nemico. Prima Pirro esca dall’Italia, poi parleremo di pace!». Con queste parole, Appio Claudio intendeva ricordare quanto fosse disonorevole trattare per la pace mentre l’invasore era ancora sul suolo patrio. I Romani, ispirati dalla determinazione di Appio Claudio, rifiutarono quindi le offerte di pace di Pirro.

È la primavera del 275 a.C., e presso Malevento (che da allora sarà rinominata Benevento) ha luogo una battaglia decisiva. Pirro ripone ancora speranze nei suoi elefanti, ma i Romani hanno ormai trovato un efficace sistema di difesa contro di loro. Gli arcieri romani lanciano frecce con stoppa infuocata sulle punte, terrorizzando i pachidermi. Presi dal panico, gli elefanti si girano e, nella fuga, travolgono le truppe epirote. Di fronte a questa sconfitta, Pirro abbandona l’Italia e fa ritorno in Epiro, vedendo sfumare i suoi piani di conquista. Nel 272 a.C., Taranto si arrende ai Romani e, nel 264 a.C., tutta l’Italia meridionale è ormai saldamente sotto il controllo di Roma.