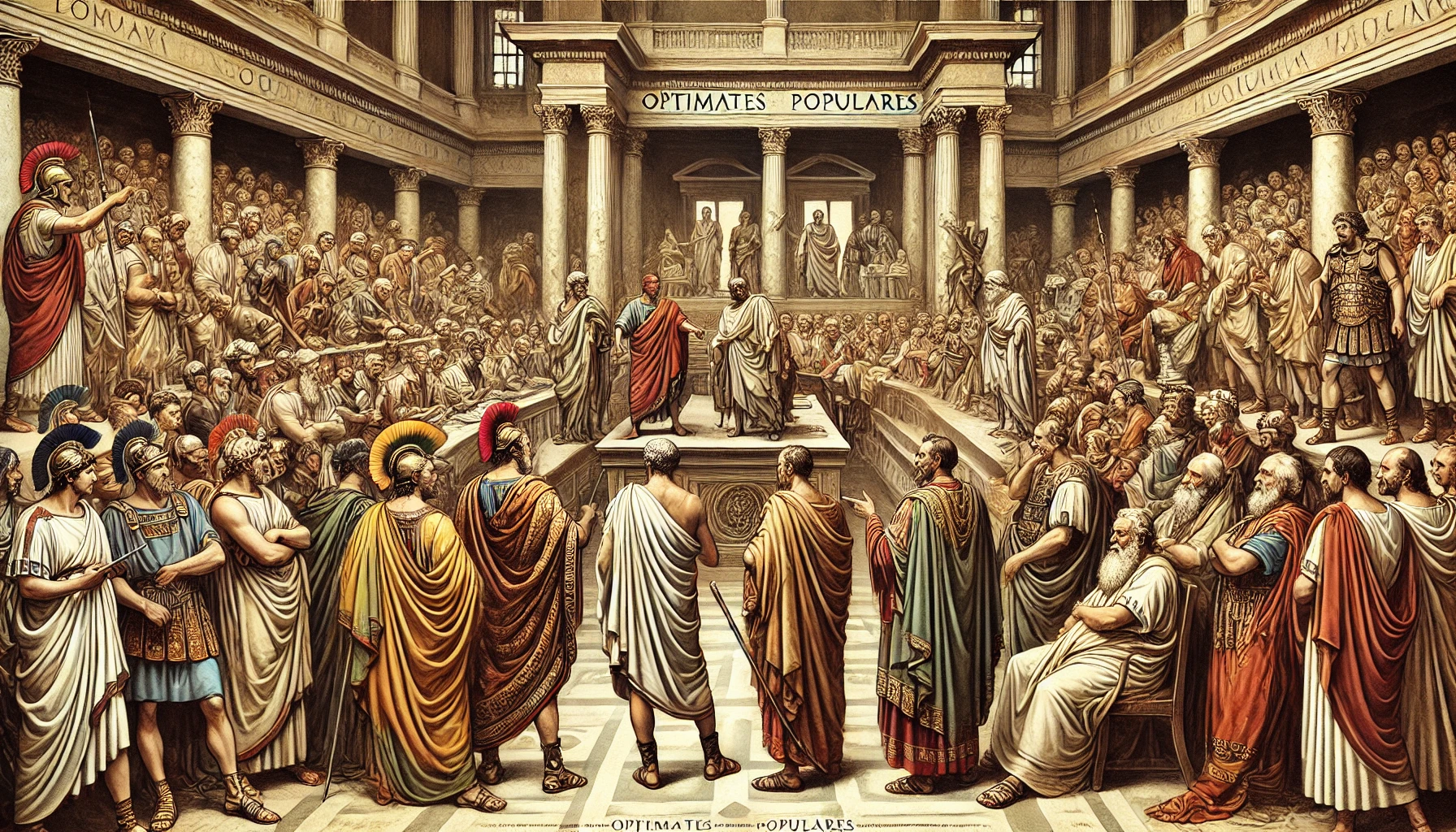A differenza di quanto avveniva nel mondo greco, per i Romani il momento ideale per celebrare i matrimoni era all’inizio dell’estate, con la seconda metà di giugno considerata particolarmente propizia. Alcuni giorni, però, erano rigorosamente evitati poiché ritenuti di cattivo auspicio: il mese di maggio, le idi, le calende e i dies nefasti erano considerati infausti.
Il matrimonio, in ambito romano, era strettamente legato al diritto e, in quanto istituzione legalmente riconosciuta, era regolato da un insieme di leggi specifiche. Lo ius connubii, ovvero il diritto di contrarre matrimonio, era inizialmente riservato a persone appartenenti alla stessa classe sociale. Una delle prime leggi che disciplinò questo ambito fu la Lex Canuleia del 445 a.C., che permise i matrimoni tra patrizi e plebei.
Questo diritto venne poi esteso a tutto l’Impero durante il principato di Caracalla. Prima della cerimonia ufficiale, era previsto un periodo di fidanzamento, lo sponsalia, che aveva inizio quando i padri dei futuri sposi accettavano formalmente la promessa di matrimonio.

Esistevano quattro principali modalità per contrarre matrimonio nell’antica Roma:
- Confaerratio: questo rito di natura religiosa si svolgeva alla presenza del pontefice massimo e del flamen diale, il sacerdote dedicato al culto di Giove Capitolino. Durante la cerimonia, gli sposi offrivano una focaccia di farro, e dieci cittadini fungevano da testimoni.
- Coemptio: di carattere più civile che religioso, questo rito consisteva in una simulazione di compravendita, in cui la sposa era simbolicamente considerata una “merce” e lo sposo l’acquirente.
- Usus: questa forma di unione si basava sulla convivenza dei fidanzati per un periodo di un anno, al termine del quale erano considerati a tutti gli effetti marito e moglie.
- Matrimonio Sine Manu: questo tipo di unione era fondato sul maritalis affectio e consentiva alla donna di rimanere sotto la patria potestà del padre, nonostante fosse regolarmente sposata. Questo permetteva di preservare l’eredità dei beni della donna all’interno della sua famiglia d’origine.
Una volta stabilita la data del matrimonio, gli sposi dovevano eseguire nello stesso giorno una serie di riti propiziatori per assicurare buona fortuna alla loro futura unione.
Il giorno del matrimonio, la sposa abbandonava la toga praetexta, un indumento bordato di porpora, e la offriva in dono a Fortuna Virginalis, la dea protettrice delle giovani spose. Per la cerimonia, indossava un abito sontuoso: la tunica recta, una lunga veste bianca, stretta in vita da una cintura che il marito avrebbe sciolto durante la prima notte di nozze. Il suo volto era coperto da un vivace velo arancione, il flammeum, che lo celava alla vista degli altri. Nel giorno tanto atteso, davanti a testimoni, parenti e amici, gli sposi offrivano un sacrificio agli dei, recitavano la formula rituale e ufficializzavano l’unione firmando il contratto matrimoniale, noto come tabulae nuptiales. La cerimonia si concludeva con la pronuba, una sorta di madrina, che univa le mani degli sposi in segno di reciproca fedeltà.
Al termine della cerimonia, iniziavano i festeggiamenti con un sontuoso banchetto, la cena nuptialis, che culminava con l’accompagnamento della sposa alla casa dello sposo. Arrivati sulla soglia della nuova dimora, il marito sollevava la moglie tra le braccia e la portava all’interno. Gli invitati, nel frattempo, intonavano canti in onore di Talassio, il dio protettore del matrimonio. Una volta entrati, il marito chiedeva alla sposa di dichiarare il suo nome, e secondo il rito tradizionale, ella rispondeva “ubi tu Caius, ego Caia”, sancendo così l’unione indissolubile dei loro destini.

Marco Rossi è un appassionato di tecnologia con oltre 20 anni di esperienza nel settore digitale. Laureato in Ingegneria Informatica, ha lavorato come consulente IT e content creator per diverse realtà online. Sul suo blog condivide guide pratiche, recensioni e approfondimenti su tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia e di Internet: dai dispositivi smart alle piattaforme di streaming, dalle novità sul web ai consigli per migliorare la sicurezza online. La sua missione è rendere comprensibili anche i temi più tecnici, aiutando lettori di ogni livello a orientarsi nel mondo digitale in continua evoluzione.