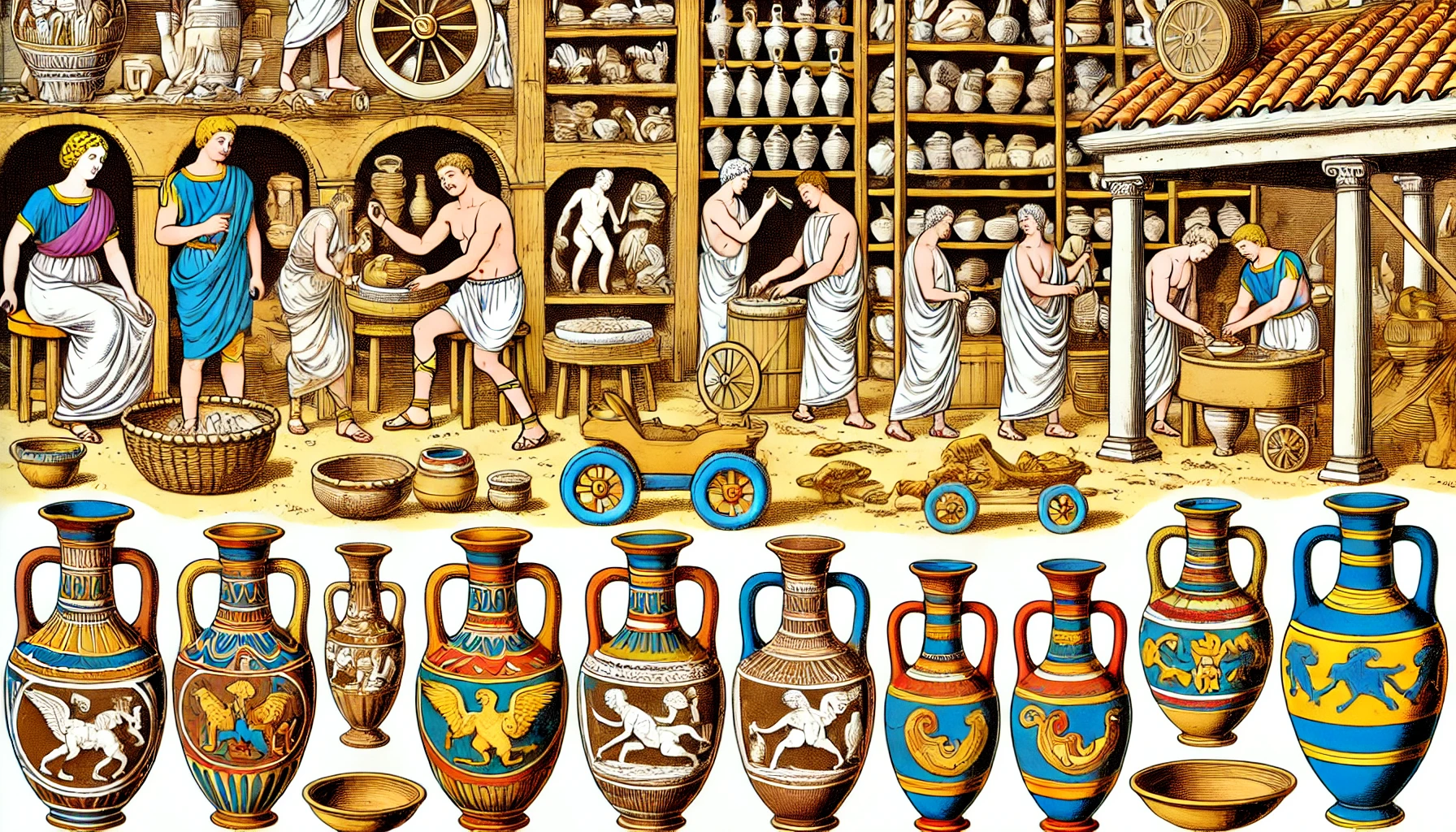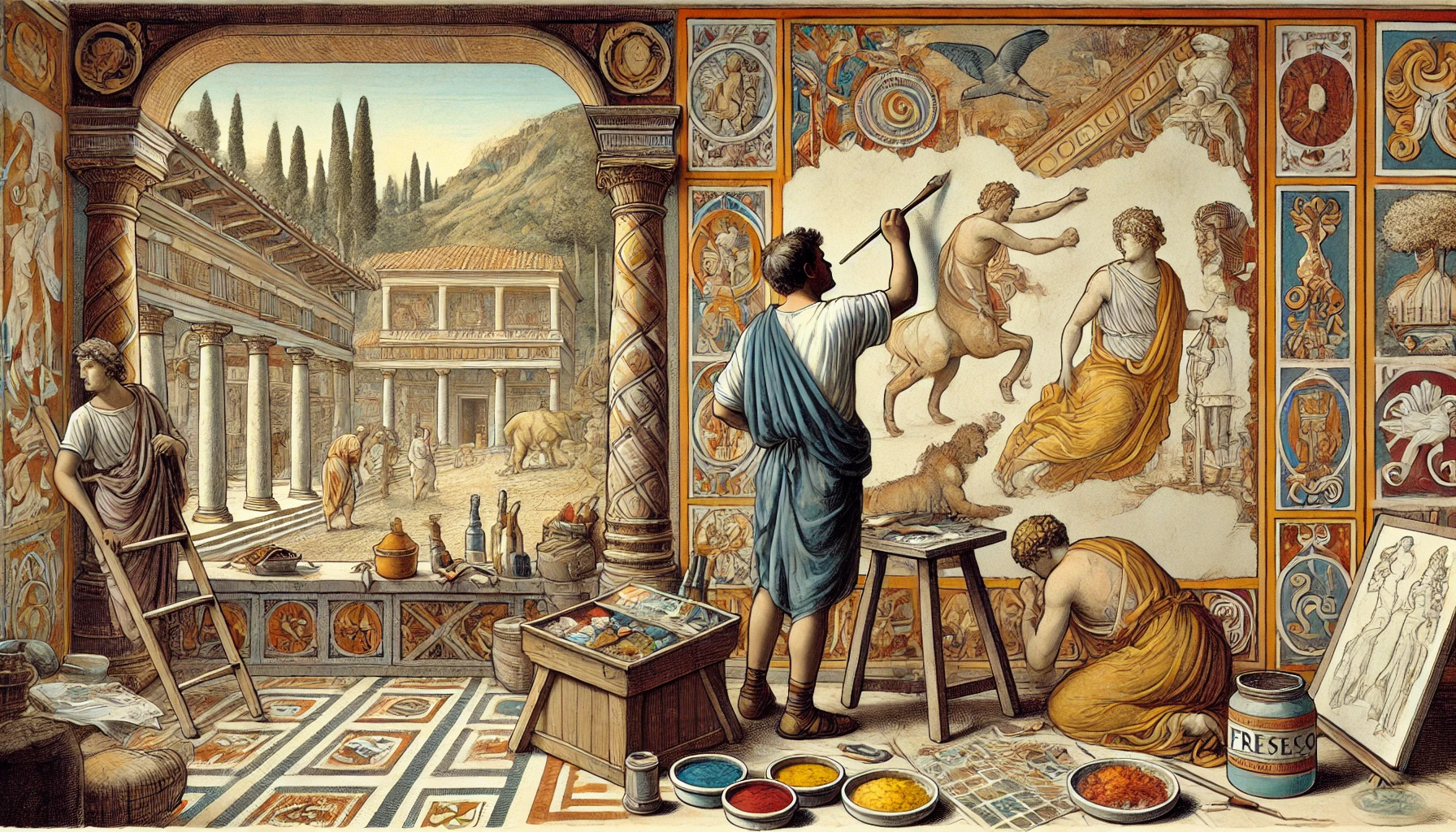Durante l’età dei Severi, l’arte scultorea si distinse per un vivace uso del colore, come dimostrato dall’Arco di Settimio Severo (imperatore dal 193 al 211) a Roma. In questo monumento, le figure sono disposte in un intreccio complesso che applica lo schema del fregio continuo, una tecnica visibile anche nella città di Leptis Magna, sull’Arco quadrifronte e sui pilastri della basilica severiana, opere realizzate da artisti appartenenti alla scuola di Afrodisia.

Un esempio straordinario di questa epoca è il magnifico sarcofago della collezione Ludovisi, ornato con una dinamica scena di battaglia. Questo sarcofago, che apparteneva a Ostiliano, figlio dell’imperatore Decio morto nel 251, raffigura il giovane principe come trionfatore, circondato dagli ufficiali della guardia del corpo, seguendo una tradizione di rappresentazione orientale. Sebbene il sarcofago sia un’opera di grande maestria, attribuita ad artisti di rilievo, non sono giunti fino a noi altri lavori degli stessi scultori.

La scultura romana del III secolo è caratterizzata prevalentemente da ritratti che esprimono tensione e sofferenza, e da sarcofagi con figure spesso sovraffollate e a volte distorte, ma dotate di una profonda espressività e con simbolismi di ispirazione orientale. Un esempio significativo di questo stile è l’arco quadrifronte di Galerio a Salonicco, dove le scene sono più allegoriche che belliche, e le teste dei tetrarchi (a rappresentare la suddivisione dell’impero in quattro parti voluta da Diocleziano) riflettono la visione stereometrica tipica dell’arte tardo-antica.
L’arte della Tarda Antichità trova le sue radici nel III secolo, un periodo segnato da una crisi così profonda da determinare la frattura dell’identità culturale, militare, amministrativa, spirituale e artistica dell’Impero Romano. Questo periodo, che si estende dalla morte di Commodo il 31 dicembre 192 all’ingresso di Costantino a Roma il 29 ottobre 312, è suddiviso in tre fasi principali:
- Il governo della dinastia dei Severi, che va dall’ascesa di Settimio Severo nel 193 alla morte di Alessandro Severo nel 235;
- Il periodo degli imperatori militari, dal 235 al 284, noto anche come anarchia militare;
- L’era di Diocleziano e della Tetrarchia, dal 284 al 312.
Le forme classicheggianti si manifestano in modo evidente nella pittura del periodo tardoantico, incluso nell’emergente arte cristiana. Lo stile artistico di questo periodo non rappresentò una vera e propria novità, ma piuttosto un’evoluzione lineare dall’arte plebea e provinciale romana, ovvero l’arte praticata dalle classi sociali inferiori o dalle aree periferiche dell’Impero. L’ascesa al potere di figure provenienti sempre più frequentemente dalle province, combinata con l’influenza delle concezioni barbariche, portò a un superamento definitivo dello stile ellenistico, che, già all’epoca di Diocleziano e Costantino, aveva perso gran parte del suo contenuto originale.
All’inizio del III secolo, il graduale distacco dagli elementi caratteristici dell’arte greca—come la prospettiva, l’uso del colore, le proporzioni, l’equilibrio organico naturalistico e la coesione formale delle figure—si trasformò in un vero e proprio abbandono nel corso di meno di un secolo.

Questa svolta fu sicuramente influenzata dalle condizioni politiche, economiche e sociali dell’epoca, che nei periodi di crisi spingevano le persone verso un desiderio di evasione e distacco, espressi attraverso un’arte che si orientava sempre più verso l’irrazionale, in parallelo con le nuove forme di spiritualità emergenti. Inoltre, la salita al potere di nuove classi legate all’esercito e alle province rurali, estranee alle manifestazioni artistiche della vecchia aristocrazia senatoria, contribuì ulteriormente a questo cambiamento artistico.
Nel III secolo, i mosaici pavimentali subirono un’evoluzione significativa, soprattutto per quanto riguarda i motivi decorativi non figurativi, con una crescente predilezione per intrecci complessi ed effetti prospettici. Si notò una maggiore autonomia del mosaico rispetto alla pittura, con l’uso di tessere più grandi che conferivano alle immagini un aspetto più marcatamente “impressionistico” rispetto alle scene dipinte, che a loro volta stavano prendendo una direzione stilistica simile.
Tra tutte le province dell’impero, le province africane occidentali, come la Byzacena, la Numidia e la Mauretania, svilupparono un linguaggio artistico nel mosaico in gran parte autonomo e originale. Qui, accanto alle tradizionali rappresentazioni mitologiche, si affermò un repertorio unico che includeva scene di caccia, agricoltura e altri aspetti della vita quotidiana, rappresentati con un realismo sorprendente. Questo periodo di fioritura artistica coincise con l’epoca d’oro della letteratura e delle controversie religiose cristiane nelle province africane occidentali.

I celebri mosaici della villa del Casale di Piazza Armerina, in Sicilia, rappresentano uno degli esempi più straordinari di quest’arte, realizzati da maestranze africane (e forse anche romane, come suggeriscono alcuni motivi di chiara derivazione urbana) su una superficie di circa 3500 m². Studi sulle strutture murarie della villa hanno datato la costruzione e i mosaici a un periodo compreso tra il 320 e il 370 d.C.
Tra le ultime grandiose opere architettoniche realizzate a Roma, spiccano le Terme di Caracalla (211-217), decorate con grandi mosaici raffiguranti atleti e gladiatori, e le Terme di Diocleziano (284-305). Meritano inoltre una menzione il magnifico palazzo di Diocleziano a Spalato e i monumenti imperiali di Treviri (l’odierna Trier in Germania), come la celebre Porta Nigra.

Marco Rossi è un appassionato di tecnologia con oltre 20 anni di esperienza nel settore digitale. Laureato in Ingegneria Informatica, ha lavorato come consulente IT e content creator per diverse realtà online. Sul suo blog condivide guide pratiche, recensioni e approfondimenti su tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia e di Internet: dai dispositivi smart alle piattaforme di streaming, dalle novità sul web ai consigli per migliorare la sicurezza online. La sua missione è rendere comprensibili anche i temi più tecnici, aiutando lettori di ogni livello a orientarsi nel mondo digitale in continua evoluzione.